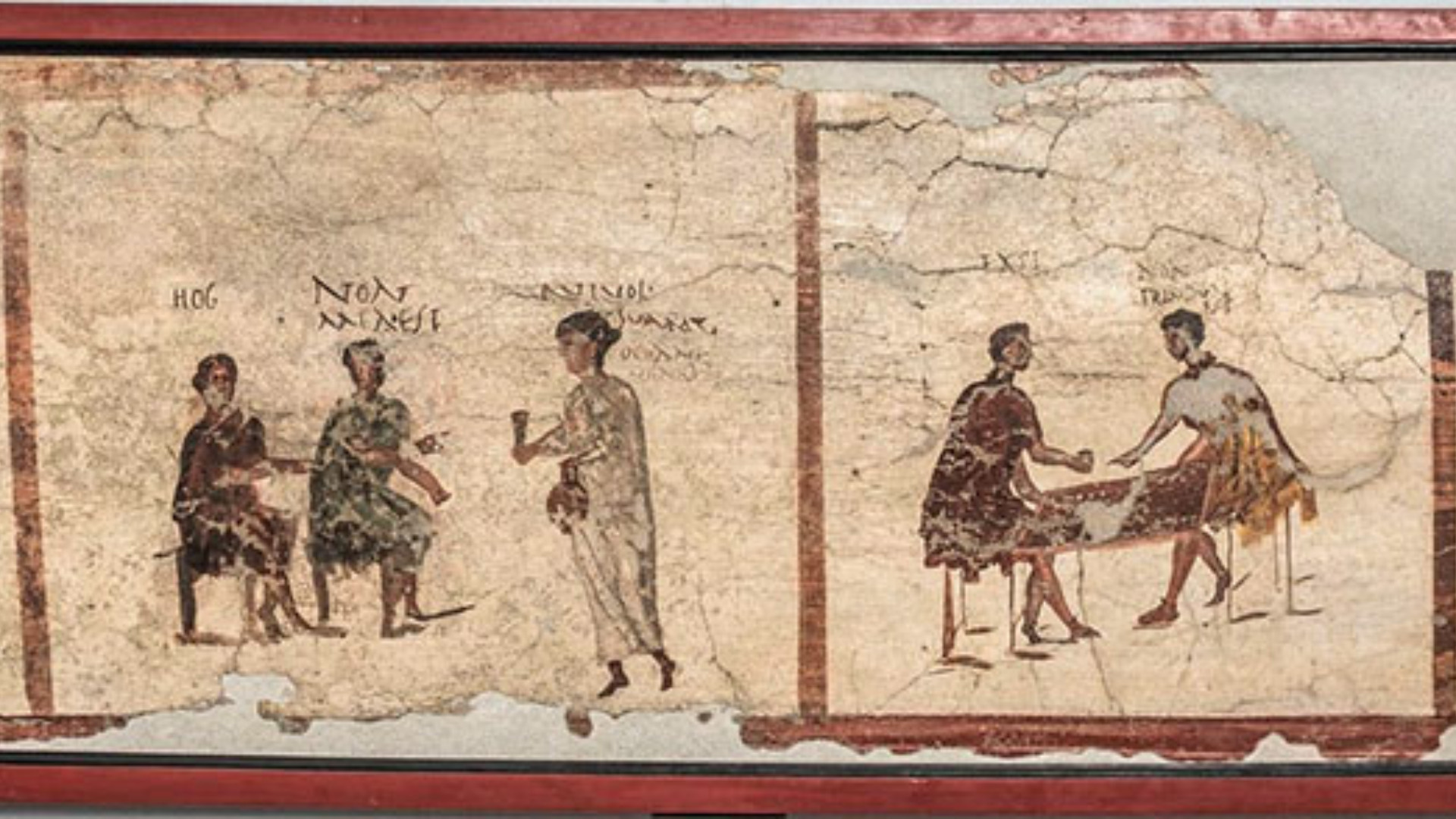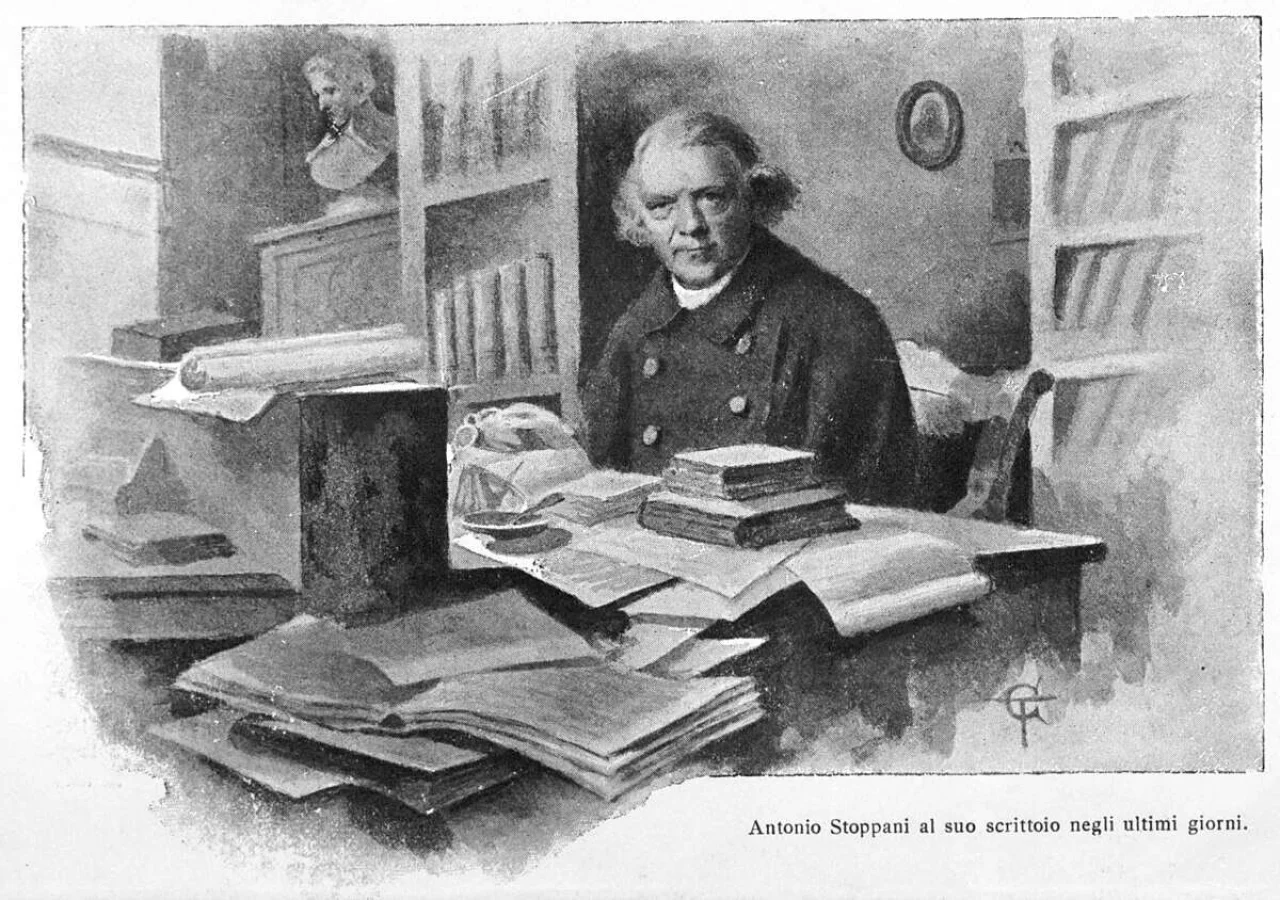SOLOLIBRI.NET di domenica 13 settembre 2020
Un romanzo di formazione, scolastica e sociale. La generazione che ha pił impresso il cambiamento: i ricordi di un ginnasiale del ’68, poi docente di lettere nella scuola per un quarantennio
di Felice Laudadio
Paolo Del Conte suona, Paolo Del Conte scrive. Lombardo del 1953, ha accompagnato per anni con la chitarra acustica grandi cantautori come Lucio Dalla Bruno Lauzi, Ron. Dopo la svolta creativa come narratore, è arrivato nelle librerie col primo libro ufficiale, La professoressa Da Ros, scoperto da Bruno Zandel e arruolato nella sua scuderia di autori nuovi per le Edizioni Oltre
Una professoressa nel titolo, una classe nella trama e un liceo, per gli adolescenti della fine degli anni Sessanta microcosmo totalizzante in un mondo che correva verso il futuro e non era più lo stesso da un giorno all’altro. Il cambiamento veniva impresso proprio dai giovani, coi capelli lunghi i maschi, lisci le ragazze e i pantaloni a zampa d’elefante gli uni e le altre. Impossibile dimenticare quella esperienza per chi l’ha vissuta: gli studenti erano protagonisti come mai prima, avevano provato a rivendicare un ruolo nella società e avevano sfondato facilmente. Si erano ritrovati a dettare il passo nelle novità, nei consumi, finanche nella politica e nel modo di concepire la realtà nel suo complesso. Erano acerbi ma motivati, più alti di una spalla, non solo fisicamente, di una compagine sociale di “matusa” grigi, musoni, lenti nel progredire e nel comprendere. Quei ragazzi del ’68 e anni seguenti erano più diversi dai genitori - e ci tenevano a dimostrarlo in ogni atteggiamento - di quanto non lo fossero state decine generazioni rispetto alle precedenti. Fino al 1965, gli universitari portavano i capelli corti tagliati alti sulla fronte, inforcavano occhiali con le montature severe di celluloide nera o marrone, indossavano abiti coi colori seri, senza fantasia. L’unica trasgressione erano le feste delle matricole, parentesi di goliardia sfrenata tollerate dagli adulti, a condizione che restassero provvisorie, contingenti, nello spazio e nel tempo. D’improvviso, i giovani si accesero di colori e immaginazione: i capelli si allungarono, le gonne si accorciarono. Casacche con le frange e bluse a fiori sostituirono le classiche camicie bianche, dalle aule sparirono i grembiuli neri che le studentesse erano costrette a indossare anche negli ultimi anni di corso. Oltre alle università, le scuole superiori erano il vero laboratorio del cambiamento, soprattutto i licei classici, e Paolo ha frequentato il Berchet, la madre di tutte le fucine della contestazione studentesca sessantottina a Milano.
Del Conte ha vissuto la scuola da una parte e dall’altra dei banchi, da studente, di quinta ginnasio, a quindici anni, l’età del romanzo, e da docente di lettere per un quarantennio, a latere della professione di musicista.
Ma di tutti i decenni passati a imparare e insegnare, quegli anni nel Berchet hanno lasciato il segno e ritornano, vivi, nel romanzo.
Una bigiata collettiva, dell’intera classe, il primo giorno di primavera, a marzo –altrove si chiama “fare filone”, “fare X” o in altri modi l’assentarsi clandestino degli alunni – è l’occasione nel romanzo per rivivere e far rivivere quel modo d’essere giovani e protagonisti.
Un sonnellino di troppo in treno, una sosta imprevista a Firenze, l’incontro con un compagno di liceo tra i più simpatici allora fanno tornare il prof. Paolo Del Conte ai tempi del ginnasiale Del Conte Paolo.
La parola che ricorreva tra gli studenti in quegli anni era: libertà. Di trascurare ad esempio quello “che l’autorità ci voleva far studiare”, non tanto per indolenza ma per il vento nuovo che soffiava. No al nozionismo, no all’autoritarismo, no a una scuola calata dall’alto e poi un sacco di altre idee.
Erano anni strani, rivolti al cambiamento, tormentati e bellissimi, di libri chiusi e di menti aperte. Il mondo non era più lo stesso e i giovanissimi si trovavano a loro agio in questo cambiamento
“alla ricerca di un’identità che solo il tempo avrebbe potuto definire, ma che con acerba inesperienza cercavamo di mostrare comunque a quel mondo adulto a cui avevamo dichiarato guerra”.
C’era la consapevolezza di assumere responsabilità, provocando reazioni inevitabili, dure, sulle giovani spalle.
Andare a scuola era bellissimo. Era un mondo nel quale in tanti si riconoscevano: amici, ragazze, il torneo di calcio, lo stare insieme, le prime discussioni di politica. E anche qualche bella lezione (qui affiora il docente di lungo corso). Impossibile una scuola senza i professori, sublimati in Bianca Da Ros, distinta cinquantenne, rocciosa friulana. Quattro ore al giorno con lei al ginnasio: insegnava italiano, latino, greco, storia e geografia, aveva un modo beffardo di mettere in difficoltà l’interrogato e tuttavia, ma “a modo suo, molto suo”, si affezionava e sapeva volere bene. Un bene da primi anni Settanta, sia chiaro, “niente effusioni”.
La quinta ginnasio era uno snodo di conferma e di guerra, ci si doveva dimostrare pronti al triennio del liceo, che avrebbe lanciato la futura classe dirigente del Paese verso il futuro, scolastico e non.
“Poi, otterrete il nulla osta per navigare verso altri lidi, ma ora siete dei marinai semplici e dovete solo eseguire gli ordini.”
Una forma di nonnismo degli adulti, vittime che si erano trasformate in carnefici. Era il viatico affidato da una generazione all’altra, ma quella del ’68, piaccia o meno, ha dato ai tempi e ai costumi una svolta mai vista prima.
Una professoressa nel titolo, una classe nella trama e un liceo, per gli adolescenti della fine degli anni Sessanta microcosmo totalizzante in un mondo che correva verso il futuro e non era più lo stesso da un giorno all’altro. Il cambiamento veniva impresso proprio dai giovani, coi capelli lunghi i maschi, lisci le ragazze e i pantaloni a zampa d’elefante gli uni e le altre. Impossibile dimenticare quella esperienza per chi l’ha vissuta: gli studenti erano protagonisti come mai prima, avevano provato a rivendicare un ruolo nella società e avevano sfondato facilmente. Si erano ritrovati a dettare il passo nelle novità, nei consumi, finanche nella politica e nel modo di concepire la realtà nel suo complesso. Erano acerbi ma motivati, più alti di una spalla, non solo fisicamente, di una compagine sociale di “matusa” grigi, musoni, lenti nel progredire e nel comprendere. Quei ragazzi del ’68 e anni seguenti erano più diversi dai genitori - e ci tenevano a dimostrarlo in ogni atteggiamento - di quanto non lo fossero state decine generazioni rispetto alle precedenti. Fino al 1965, gli universitari portavano i capelli corti tagliati alti sulla fronte, inforcavano occhiali con le montature severe di celluloide nera o marrone, indossavano abiti coi colori seri, senza fantasia. L’unica trasgressione erano le feste delle matricole, parentesi di goliardia sfrenata tollerate dagli adulti, a condizione che restassero provvisorie, contingenti, nello spazio e nel tempo. D’improvviso, i giovani si accesero di colori e immaginazione: i capelli si allungarono, le gonne si accorciarono. Casacche con le frange e bluse a fiori sostituirono le classiche camicie bianche, dalle aule sparirono i grembiuli neri che le studentesse erano costrette a indossare anche negli ultimi anni di corso. Oltre alle università, le scuole superiori erano il vero laboratorio del cambiamento, soprattutto i licei classici, e Paolo ha frequentato il Berchet, la madre di tutte le fucine della contestazione studentesca sessantottina a Milano.
Del Conte ha vissuto la scuola da una parte e dall’altra dei banchi, da studente, di quinta ginnasio, a quindici anni, l’età del romanzo, e da docente di lettere per un quarantennio, a latere della professione di musicista.
Ma di tutti i decenni passati a imparare e insegnare, quegli anni nel Berchet hanno lasciato il segno e ritornano, vivi, nel romanzo.
Una bigiata collettiva, dell’intera classe, il primo giorno di primavera, a marzo –altrove si chiama “fare filone”, “fare X” o in altri modi l’assentarsi clandestino degli alunni – è l’occasione nel romanzo per rivivere e far rivivere quel modo d’essere giovani e protagonisti.
Un sonnellino di troppo in treno, una sosta imprevista a Firenze, l’incontro con un compagno di liceo tra i più simpatici allora fanno tornare il prof. Paolo Del Conte ai tempi del ginnasiale Del Conte Paolo.
La parola che ricorreva tra gli studenti in quegli anni era: libertà. Di trascurare ad esempio quello “che l’autorità ci voleva far studiare”, non tanto per indolenza ma per il vento nuovo che soffiava. No al nozionismo, no all’autoritarismo, no a una scuola calata dall’alto e poi un sacco di altre idee.
Erano anni strani, rivolti al cambiamento, tormentati e bellissimi, di libri chiusi e di menti aperte. Il mondo non era più lo stesso e i giovanissimi si trovavano a loro agio in questo cambiamento
“alla ricerca di un’identità che solo il tempo avrebbe potuto definire, ma che con acerba inesperienza cercavamo di mostrare comunque a quel mondo adulto a cui avevamo dichiarato guerra”.
C’era la consapevolezza di assumere responsabilità, provocando reazioni inevitabili, dure, sulle giovani spalle.
Andare a scuola era bellissimo. Era un mondo nel quale in tanti si riconoscevano: amici, ragazze, il torneo di calcio, lo stare insieme, le prime discussioni di politica. E anche qualche bella lezione (qui affiora il docente di lungo corso). Impossibile una scuola senza i professori, sublimati in Bianca Da Ros, distinta cinquantenne, rocciosa friulana. Quattro ore al giorno con lei al ginnasio: insegnava italiano, latino, greco, storia e geografia, aveva un modo beffardo di mettere in difficoltà l’interrogato e tuttavia, ma “a modo suo, molto suo”, si affezionava e sapeva volere bene. Un bene da primi anni Settanta, sia chiaro, “niente effusioni”.
La quinta ginnasio era uno snodo di conferma e di guerra, ci si doveva dimostrare pronti al triennio del liceo, che avrebbe lanciato la futura classe dirigente del Paese verso il futuro, scolastico e non.
“Poi, otterrete il nulla osta per navigare verso altri lidi, ma ora siete dei marinai semplici e dovete solo eseguire gli ordini.”
Una forma di nonnismo degli adulti, vittime che si erano trasformate in carnefici. Era il viatico affidato da una generazione all’altra, ma quella del ’68, piaccia o meno, ha dato ai tempi e ai costumi una svolta mai vista prima.
leggi l'articolo integrale su SOLOLIBRI.NET
| SCHEDA LIBRO | Segnala | Ufficio Stampa |